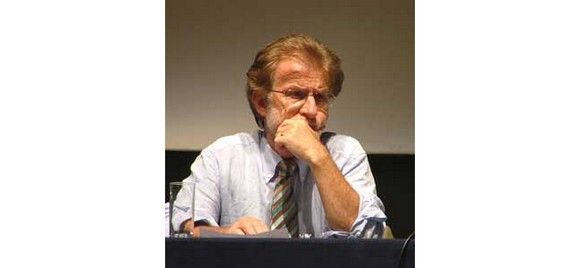
Oggi c’è il rischio che i padroni del linguaggio, a colpi di slogan, mandino in esilio i cittadini della parola. Chi comunica ha una grande responsabilità
Magnifico Dionigi! Professore ordinario di Letteratura latina, Rettore dell’Università di Bologna dal 2009 al 2015, intellettuale doc, pensatore infaticabile, maestro “di color che sanno” e di tutti quelli che sono attratti dal suo carisma, Ivano Dionigi è una luce viva che si staglia fra i chiaroscuri di quest’epoca in penombra. Anche un corso di formazione per giornalisti, con lui, si trasforma in una Lectio magistralis. E una professione come la nostra, sempre più tarata sulla quantità e la velocità, trova autentico nutrimento nei concetti fondamentali di un Maestro della Parola.
Da tempo si interroga sulla centralità della parola. Nel suo ultimo libro Il presente non basta. La lezione del latino va al cuore del problema e si pone diverse domande. Una per tutte: qual è l’eredità che lo studio dei classici lascia a tutti noi?
«Le domande partono molto dall’oggi e da tre paradossi. Il primo è che nell’era in cui c’è il massimo dei mezzi di comunicazione, c’è un minimo di capacità d’intesa, insomma aumentano i cittadini di Babele. C’è un uso improprio delle parole: le parole non corrispondono più, hanno una separazione dalle cose che vogliono significare. Un secondo paradosso è che quando si parla di Seneca, Agostino, Lucrezio nell’Aula Magna di Santa Lucia ci sono 1500 persone e l’80 per cento è pubblico giovanissimo, invece se si fa un incontro sulla politica con gli stessi relatori ci sono solo 100 over 60. Come mai? Qual è il problema? Terzo paradosso: oggi non si fa che parlare di rinascimento, dai politici agli amministratori. Rinascimento urbano, ecologico, architettonico, fiscale, però questo rinascimento digitale non arriva mai. Forse il rinascimento non ha rottamato il passato, ma ha rottamato il presente. La mia impressione è che si cerchino subito delle risposte e l’ars interrogandi, quella di porre le domande, rispetto all’ars respondendi, soffre. Allora, io ho scelto una chiave interpretativa, che è quella dei classici e segnatamente quella della lingua, per vedere cosa apre. La lingua latina, che è madre dell’italiano e delle lingue indoeuropee – ed è la lingua che hanno parlato ininterrottamente la chiesa, la politica e la scuola fino al XX secolo – è uno strumento linguistico che fa riscoprire la genuinità, l’originalità, la proprietà, la centralità della parola (che oggi è massacrata), proprio perché risale ai suoi valori originari. Poi c’è la dimensione del tempo. Oggi c’è una sproporzione: grazie alla tecnologia (che è la forma avanzata della conoscenza) e a questo digitale abbiamo sviluppato massicciamente la dimensione spaziale con il costo di esserci un po’ asserviti al monoteismo tecnologico che riconosce al consumo l’unico e vero dio. E il tempo dove è andato a finire? Tutto è presente, presentificato, nello schermo scintillante».
E allora?
«Allora, nello spazio siamo planetari, totali, universali, mondiali, ma per il tempo siamo dei provinciali, crediamo che il mondo sia iniziato hic et nunc, qui e adesso con noi, invece di questo patrimonio, di questo capitale che è la vita le azioni le deteniamo noi, i trapassati e quelli che verranno dopo. È una cosa più seria la vita, più completa, più universale. E poi c’è il rischio dell’inferno dell’uguale: di fronte a questo presente tutti hanno lo stesso linguaggio o meglio gli stessi vocaboli, tutti hanno la stessa moda, gli stessi pensieri mignon, corti. Tutto è uguale. L’inferno non sono gli altri, come ha detto Sartre, l’inferno è questa dimensione dove tutto è uguale e nessuno ha il pathos della differenza: l’eros e il pathos delle cose diverse che ti nobilitano, ti fanno pensare, ti rendono fecondo, ti mettono in crisi. Questo eros e pathos della distanza, della differenza, della lontananza. Cosa sa del presente chi conosce solo il presente? Cosa sa di Bologna chi conosce solo Bologna? Cosa sa di se stesso uno che conosce solo se stesso? Allora, è importante conoscere la lingua alta da cui proveniamo. E i classici ci interessano non perché sono attuali, ma perché sono paradossalmente inattuali. L’attualità, il giornale di oggi è già superato dall’online di ieri sera: quell’online così volatile. Invece c’è bisogno di appoggiare i piedi, di radicarsi. Allora, io dico con un’espressione un po’ a slogan, che il latino ti apre il tempio del tempo: è la lingua da cui deriva l’italiano, è la lingua che ha parlato l’Europa, è una lingua segmentata in presente, passato e futuro che connette tutti i tempi con la famosa consecutio temporum. E poi non solo la lingua latina, ma tutta la civiltà romana è sotto il segno del tempo: la Colonna Traianea è un racconto che si snoda. Tutto è sotto il segno del tempo. Anche il diritto, perché nell’antica Roma il diritto non era l’opera di un legislatore, ma un’opus commune et perpetua, apparteneva a tutti. Allora, rispetto al discorso della sproporzione tra spazio e tempo, mi dispiace per i giovani perché tutto questo uguale per loro oggi è letale, è un gas nervino. In classe mi piacerebbe vedere il professore del digitale e quello di latino a confronto. Non è che voglia accanirmi sul latino, per carità: dico latino, ma significa anche italiano, storia, filosofie umane. Allora, il professore del digitale ti fa capire la dilatazione dello spazio e quello di latino ti fa capire il tempo».
Alla luce di quanto ha affermato, crede che la comunicazione e l’informazione siano cambiate in modo profondo nel corso del tempo? Adesso ci sono nuove tecnologie, c’è una maggiore velocità di produzione e diffusione delle notizie ma, secondo lei, qual è il nodo fondamentale della professione giornalistica?
«La mia preoccupazione è sempre la stessa. Soprattutto chi deve comunicare ha una grande responsabilità, per cui le parole, i verba devono corrispondere alle cose, ai fatti. Una cosa è l’interpretazione dei fatti, altra cosa è raccontarli per quello che sono. E allora, quando vedo che le notizie cambiano da una testata all’altra e ci sono dei giornalisti che ti fanno le prediche, non lo sopporto perché c’è qualcosa di malato. Va bene? Scusi la franchezza».
Restiamo sul versante dell’informazione. Lei era Rettore dell’Alma Mater quando è stato ripreso il progetto del Master in giornalismo di Bologna che è stato recentemente varato.
«Lo avevano affossato e io l’ho resuscitato».
Ecco. Siccome l’ha rilanciato, che obiettivi pensa si debba porre oggi un master in giornalismo?
«Ho un’idea molto chiara, come per la scuola. A cosa deve servire un master, come una scuola? Deve dare la competenza e la formazione. Lo dico anche nel mio libro, insieme al Rettore di Harvard che afferma: “se voi credete di venire qui a imparare un mestiere, poi quando uscite magari quel mestiere non c’è più, vi sbagliate. Allora per cosa venite? Voi dovete venire qui a imparare a imparare, perché nella vita dovete reimparare continuamente”. Per cui bisogna dare i fondamentali. Siamo nell’era delle conoscenze, dei saperi orizzontali, allora cerchiamo di dare fondamenti alla cultura. Che a Bologna la retorica classica nei corsi di comunicazione non si sia mai fatta, mi sembra un vulnus. La differenza la fa la cultura oggi: saper parlare bene, saper dare le notizie, saper usare la parola. Non confondiamo i fondamenti con le tecnicalità. Come tutta questa enfasi dell’inglese e dell’informatica a scuola che devono trovar posto e quindi eliminare il greco e il latino. Ma l’informatica e l’inglese i ragazzini la imparano già dal latte materno, per l’inglese vanno all’estero. Cominciamo a distinguere ciò che è fondante, ciò che è formativo e rimane per la vita, in qualunque mestiere. Poi è chiaro che servono delle specificità, però costruiamo una base solida, di saperi forti. Oggi va di moda l’insegnante facilitatore, è una bestemmia: ci vogliono gli scarponi chiodati, i docenti devono essere dei difficilitatori della vita per i ragazzi, perché la vita è un sesto grado».
Per chiudere. Ha affermato che una società che ha fatto del linguaggio il suo fondamento e dubita del linguaggio vuol dire che è una società finita. Siamo a questo punto?
«Oggi c’è il rischio che i padroni del linguaggio, a colpi di slogan, mandino in esilio i cittadini della parola».
Franca Silvestri
(26 ottobre 2016)

