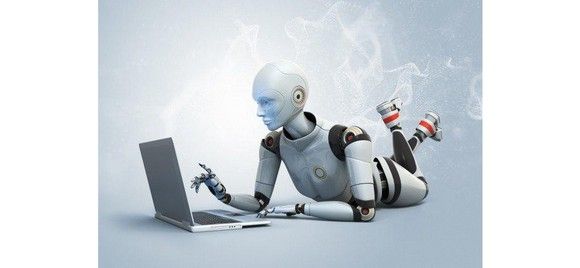
Pansa, Besozzi e gli articoli scritti dai robot. Riflessioni sul rapporto tra informazione, robotica e deontologia del Consigliere dell’OdG regionale Silvestro Ramunno
L’informazione è sempre più considerata una commodities, merce indistinta, con poca attenzione alla qualità del contenuto e al produttore. Una situazione che riguarda l’intera società, la digital transformation e i modi di fruizione dei contenuti. Ma anche i giornalisti sono chiamati a dare un contributo, con le poche “armi” che hanno a disposizione.
I robot sostituiranno i giornalisti? La risposta, allo stato attuale della conoscenza, è no. Ma non c’è da essere rassicurati perché sempre più l’informazione è considerata una commodity, merce indistinta senza variazioni di qualità, che sia prodotta da un robot o da un giornalista in carne ed ossa.
Quelle che seguono sono alcune riflessioni sul rapporto tra informazione, robot e deontologia e sullo scenario nel quale noi giornalisti operiamo, fatte nel corso di un seminario formativo dedicato alla figura di Alberto Bergamini, l’inventore della Terza Pagina e tra i protagonisti della nascita del giornalismo moderno.
Premessa: quando parliamo di robot non dobbiamo pensare all’umanoide dei film. I “nostri” robot sono sistemi di intelligenza artificiale, algoritmi capaci di trovare informazioni e di elaborarle in un qualcosa di simile ad un articolo. Le esperienze più avanzate sono nel campo dell’informazione finanziaria, vista la standardizzazione della comunicazione dei risultati economici. Ma anche il testo generato da un robot con i dati di fatturato-ebitda-utile viene ancora validato da un giornalista prima della pubblicazione.
Il processo di sostituzione robot/umani è molto più lento di quanto immaginato qualche tempo fa e può essere utile ribadire che i robot non hanno una propria etica, ma imparano dalle informazioni che ricevono: scriviamo milioni di articoli con la corretta deontologia, loro “impareranno” a fare lo stesso. Altrimenti sarà un disastro.
Ma questo è uno scenario futuribile, oggi il punto è un altro: perché lo splendido articolo di Giampaolo Pansa sul Vajont (Scrivo da un paese che non esiste più) o quello di Tommaso Besozzi sul Bandito Giuliano (Di sicuro c’è solo che è morto) oggi hanno lo stesso valore di un abstract di poche righe generato da un algoritmo, che magari può avere molte più visualizzazioni grazie ad accorgimenti SEO? Come ridare valore al giornalismo di qualità (lo chiamiamo così per esigenze di sintesi, ma ci sarebbe molto da dire…)?
Sono temi estremamente complessi, che non riguardano solo il giornalismo. Sono questioni culturali, sociali, antropologiche e riguardano il modo in cui ci rapportiamo con la fruizione dei contenuti nella società digitale: se teniamo alta l’attenzione per non più di tre secondi prima di scrollare alla foto o al tweet successivo, non c’è giornalismo di qualità che tenga. Se poi ci mettiamo che siamo nell’era della post verità (dove le emozioni e le opinioni personali contano più dei fatti), della disintermediazione (ma sarebbe meglio parlare di nuova intermediazione), delle bolle nelle quali ci chiudiamo con la complicità degli algoritmi (ma siamo noi che diciamo agli algoritmi cosa ci piace e cosa no), dei bias cognitivi (sempre più conflitti intrattabili al posto del confronto costruttivo), ne viene fuori uno scenario di estrema complessità, in cui non basta il lanternino del giornalista ad illuminare la strada da seguire.
Il giornalismo, qui inteso come tutto l’ecosistema della produzione di contenuti, ha avuto delle responsabilità nella creazione di una percezione distorta della realtà, che poi ha impattato negativamente sulla qualità del dibattito pubblico. Abbiamo parlato migliaia di volte di No Vax, ma ci siamo mai chiesti se i vaccini siano aumentati o diminuiti? Abbiamo parlato migliaia di volte di ridistribuzione dei migranti tra i Paesi Europei, ma ci siamo mai chiesti se in Italia (che ha una bassa percentuale di migranti residenti) dobbiamo farli arrivare o partire? Abbiamo scritto migliaia di articoli polemici sulla “stangata” dei sacchetti bio per la frutta al supermercato (ci costano due/tre euro l’anno) e non abbiamo mai pensato al fatto che gli incentivi alle energie fossili e rinnovabili (sì, tutte e due) costano 550 euro a persona l’anno. Abbiamo scritto migliaia di articoli sulla piaga degli omicidi, 357 in totale compresi i femminicidi, ma dobbiamo trovare con la lente d’ingrandimento articoli sui 10 mila morti che provoca ogni anno in Italia l’antibiotico resistenza.
Abbiamo scambiato lo scemo del villaggio con il villaggio tout court? Abbiamo scambiato l’interesse pubblico con l’interesse del pubblico?
Prima di proseguire con il “come il giornalismo può provare a risalire la china”, è utile un riferimento ai conflitti intrattabili per renderci conto che la questione della perdita di peso dell’informazione va molto oltre i giornalisti e prescinde dalla qualità dell’informazione. Prendiamo (fisicamente) un terrapiattista, portiamolo nello spazio a fargli vedere la sfera celeste, facciamolo dialogare con i più autorevoli astronomi, scriviamo il migliore articolo sul tema della sfericità della Terra… cambierà idea? Gli studi sui comportamenti delle persone in rete dicono che non solo non cambierà idea, ma diventerà un terrapiattista più radicale di prima. In questo scenario, la cui complessità è questione per sociologi, psicologi, antropologi, medici, storici, politici, insegnanti etc… la “verità” del giornalista può dare solo piccoli contributi, le armi a disposizione sono quasi completamente spuntate. Quasi, non del tutto!
Cosa possiamo fare? Intanto non guasterebbe un po’ di media literacy e di educazione alla bellezza per avere persone in grado di distinguere un Besozzi da un robot, ma non guasterebbe nemmeno capire come le persone si rapportano con noi e tra di loro attraverso gli articoli che produciamo. Qualche analisi l’ha fatta la Columbia University, scoprendo che articoli empatici e complessi, con più punti di vista, hanno maggiore possibilità di generare confronto e essere ritenuti di qualità. Forse è giunto il momento di prendere atto che raccontare il mondo dal punto di vista del maschio bianco di mezza età, che si muove con l’auto privata, non è più rappresentativo della società. Ci siamo mai chiesti perché diciamo sempre che una strada è chiusa alle auto e non aperta ai pedoni, ai bambini, ai ciclisti o è più sicura per gli anziani e le persone in generale? Riusciremo mai a non fare titoli come “le tasse sono calate” o “le tasse sono aumentate”, lo stesso giorno su due testate differenti? Riusciremo mai a dire che il principale killer nel mondo è l’acqua sporca e che ne uccide più lo smog che la criminalità organizzata, senza che sembri che si voglia sminuire la pericolosità di quest’ultima? Riusciremo a riscoprire le migliaia di sfumature che ci sono tra il bianco e il nero?
È una parte della grande sfida che abbiamo davanti, che ci riguarda anche come Ordine dei Giornalisti, soprattutto per la formazione professionale. Impariamo a rappresentare la complessità in maniera empatica e a farlo nel rispetto dei principi deontologici che regolano la nostra professione; senza di quelli saremmo solo commodities, merce indistinta in un immenso bazar dove a nessuno interessa chi sia il produttore. Fa sempre un bell’effetto rileggere l’articolo 2 del nostro Testo Unico dei Doveri del Giornalista. È il nostro cucchiaino per svuotare il mare, da qualche parte bisognerà iniziare.
Silvestro Ramunno
Consigliere regionale dell’Ordine dei giornalisti dell’Emilia-Romagna
(3 dicembre 2019)
Il seminario a cui si fa riferimento in questo articolo si è svolto il 15 novembre scorso a San Giovanni in Persiceto (Bologna). In quella occasione la Fondazione dell’Ordine dei giornalisti ha potuto contare sulla preziosa collaborazione dell’Associazione Olindo Malagodi, presieduta dalla collega Fulvia Sisti.

